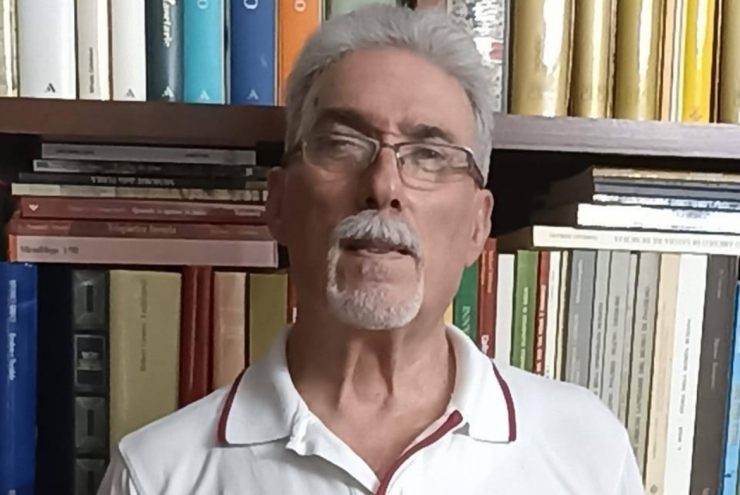Le Metamorfosi di Ovidio. I, 253 – 434: Il Diluvio dal punto di vista greco-romano, assenza di Virtus.

I, 253 – 434
- Iamque erat in tōtās sparsūrus fulmina terrās;
sed timuit, nē forte sacer tot ab ignibus aether
- conciperet flammās longusque ardesceret axis.
Esse quoque in fātīs reminiscitur adfore tempus,
quō mare, quō tellus correptaque rēgia caelī
ardeat et mundī mōlēs operōsa labōret.
Tēla repōnuntur manibus fabricāta Cyclōpum:
- poena placet diversa, genus mortāle sub undīs
perdere et ex omnī nimbōs dēmittere caelō.
Prōtinus Aeoliīs Aquilōnem claudit in antrīs
et quaecumque fugant inductās flāmina nūbēs,
ēmittitque Notum: madidīs Notus ēvolat ālīs
- terribilem piceā tectus cālīgine vultum:
barba gravis nimbīs, cānīs fluit unda capillīs,
fronte sedent nebulae, rōrant pennaeque sinusque;
utque manū lātē pendentia nūbila pressit,
fit fragor: hinc densī funduntur ab aethere nimbī.
- Nuntia Iūnōnis variōs indūta colōrēs
concipit Īris aquās alimentaque nūbibus adfert:
sternuntur segetēs et dēplōrāta colōnīs
vōta iacent longīque perit labor inritus annī.
Nec caelō contenta suō est Iovis ira, sed illum
275 caeruleus frāter iuvat auxiliāribus undīs.
Convocat hīc amnēs, quī postquam tecta tyrannī
intrāvēre suī, ‘nōn est hortāmine longō
nunc’ ait ‘ūtendum: vīrēs effundite vestrās;
sic opus est. Aperīte domōs ac mōle remōtā
280 flūminibus vestrīs tōtās inmittite habēnās.’
iusserat: hī redeunt ac fontibus ōra relaxant
et dēfrēnātō volvuntur in aequora cursu.
Ipse tridente suō terram percussit, at illa
intremuit mōtūque viās patefēcit aquārum.
285 Exspatiāta ruunt per apērtōs flūmina cāmpōs
cumque satīs arbusta simul pecudesque virōsque
tectaque cumque suīs rapiunt penetrālia sacrīs.
Siqua domus mansit potuitque resistere tantō
indeiecta malō, culmen tamen altior hūius
290 unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turrēs;
iamque mare et tellus nullum discrimen habēbant:
omnia pontus erant, deerant quoque lītora pontō.
Occupat hīc collem, cumbā sedet alter adunca
et dūcit rēmōs illīc, ubi nūper arārat;
295 ille suprā segetēs aut mersae culmina villae
nāvigat, hic summā piscem dēprendit in ulmō;
fīgitur in viridī, sī fors tulit, ancora prātō,
aut subiecta terunt curvae vīnēta carīnae,
et, modo quā gracilēs grāmen carpsēre capellae,
300 nunc ibi dēformēs pōnunt sua corpora phōcae.
Mīrantur sub aquā lūcōs urbēsque domōsque
Nēreidēs, silvasque tenent delphīnes et altīs
incursant ramīs agitātaque rōbora pulsant.
Nat lupus inter ovēs, fulvōs vehit unda leōnes
305 unda vehit tigrēs, nec vīrēs fulminis āprō,
crura nec ablātō prōsunt velōcia cervō,
quaesītisque diū terrīs, ubi sistere possit,
in mare lassatīs volucrīs vaga dēcidit ālis.
Obruerat tumulōs inmensa licēntia pontī,
310 pulsābantque novī montāna cacūmina fluctūs.
Maxima pars undā rapitur: quibus unda pepercit,
illōs longa domant īnōpī ieiūnia victū.
Sēparat Aoniōs Oetaeīs Phōcis ab ārvīs,
terra ferax, dum terra fuit, sed tempore in illō
315 pars maris et lātus subitārum campus aquārum;
mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,
nōmine Parnāsus, superantque cacūmina nūbēs:
hīc ubi Deucalion (nam cētera texerat aequor)
cum consorte torī parvā rate vectus adhaesit,
320 Corycidās nymphās et nūmina montis adōrant
fātidicamque Themin, quae tunc oracla tenēbat:
nōn illō melior quisquam nec amāntior aequī
vīr fuit aut illā metuentior ulla deōrum.
Iuppiter ut liquidis stagnāre palūdibus orbem
325 et superesse virum dē tot modo mīlibus ūnum
et superesse videt dē tot modo mīlibus ūnam,
innocuōs ambō, cultōrēs nūminis ambō,
nūbila disiēcit nimbīsque aquilōne remōtīs
et caelō terrās ostendit et aethera terrīs.
330 Nec maris īra manet, positōque tricuspide tēlō
mulcet aquās rector pelagī suprāque profundum
exstantem atque umerōs innātō mūrice tectum
caeruleum Tritōna vocat conchaeque sonantī
inspirāre iubet fluctusque et flūmina signō
335 iam revocāre datō: cava būcina sūmitur illī,
tortilis, in lātum quae tūrbine crescit ab īmo,
būcina quae mediō concēpit ubi āëra pontō,
lītora vōce replet sub utrōque iacentia Phoebo.
Tunc quoque, ut ōra Deī madidā rōrantia barbā
340 contigit et cecinit iussōs inflata receptūs,
omnibus audīta est tellūris et aequoris undīs
et, quibus est undīs audīta, coercuit omnēs.
Iam mare lītus habet, plenōs capit alveus amnēs,
flūmina subsīdunt collesque exīre videntur,
345 surgit humus, crescent loca dēcrescentibus undīs,
postque diem longam nūdāta cacūmina silvae
ostendunt līmumque tenent in fronde relictum.
Redditus orbis erat; quem postquam vidit inanem
et dēsōlātās agere alta silentia terrae.
350 Deucalion lacrimīs ita Pyrrham adfātur obortīs:
Ō soror, ō coniunx, ō fēmina sōla superstes,
quam commune mihī genus et patruēlis orīgo
deinde torus iunxit, nunc ipsa perīcula iungunt,
terrārum, quascumque vident occāsus et ortus,
355 nos duo turba sumus: possedit cētera pontus.
Haec quoque adhuc vītae non est fidūcia nostrae
certa satis; terrent etiam nunc nūbila mentem.
Quis tibi, sī sine mē fātīs ērepta fuisses,
nunc animus, miseranda, foret? Quō sōla timōrem
360 ferre modo posses? Quō consolante dolēres?
Namque ego, crede mihī, sī tē quoque pontus habēret,
tē sequerer, coniunx, et mē quoque pontus haberet.
Ō utinam possim populōs reparāre paternīs
artibus atque animās formātae infundere terrae!
365 nunc genus in nōbis restat mortāle duōbus
(sic vīsum superīs) hominumque exempla manēmus.”
Dixerat, et flēbant; placuit caeleste precāri
numen et auxilium per sacrās quaerere sortēs.
Nulla mora est: adeunt pariter Cēphīsidas undās,
370 ut nondum liquidās, sic iam vada nōta secantēs.
Inde ubi lībātōs inrōrāvēre liquōrēs
vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae
ad dēlubra deae, quōrum fastīgia turpi
pallēbant muscō stabantque sine ignibus ārae.
375 Ut templī tetigēre gradūs, procumbit uterque
prōnus humī gelidōque pavens dedit oscula saxō
atque ita “sī precibus” dixērunt “nūmina iustīs
victa remollescunt, sī flectitur īra deōrum,
dic, Themi, quā generis damnum reparābile nostri
380 arte sit, et mersīs fer opem, mītissima, rēbus.”
Mota Dea est sortemque dedit: “discēdite templō
et velāte caput cintāsque resolvite vestēs
ossaque post tergum magnae iactāte parentis.”
Obstipuēre diū, rumpitque silentia voce
385 Pyrrha prior, iussisque Deae pārēre recūsat,
detque sibī veniam, pavidō rogat ōre pavetque
laedere iactatīs maternās ossibus umbrās.
Intereā repetunt caecīs obscūra latebrīs
verba datae sortis sēcum inter sēque volūtant.
390 Inde Prōmetides placidīs Epimēthida dictīs
mulcet et “aut fallax” ait “est sollertia nōbis,
aut (pia sunt nullumque nefās ōrācula suādent)
magna parens terra est: lapidēs in corpore terrae
ossa reor dīcī: iacere hōs post terga iubemur.”
395 Coniugis auguriō quamquam Titānia mōta est,
spēs tamen in dubiō est: adeō celestibus ambo
diffīdunt monitīs, sed quid temptāre nocēbit?
Discendunt vēlantque caput tunicāsque recingunt
et iussōs lapidēs sua post vestīgia mittunt.
400 Saxa (quis hoc credat, nīsī sit prō teste vetustās?)
pōnere dūritiem coepēre suumque rigōrem
mollīrīque morā mollītaque dūcere formam.
Mox ubi crēvērunt nātūraque mītior illīs
contigit, ut quaedam, sic non manifesta vidērī
405 forma potest hominis, sēd, uti dē marmore coepta,
non exacta satis rudibusque simillima signīs.
Quae tamen ex illīs aliquō pars ūmida sūcō
et terrēna fuit, versa est in corporis usum;
quod solidum est flectīque nequit, mutātur in ossa;
410 quae modo vēna fuit, sub eōdem nōmine mansit;
inque brevī spatiō superōrum nūmine saxa
missa virī manibus faciem traxēre virōrum,
et dē fēmineō reparāta est fēmina iactū.
Inde genus dūrum sumus experensque labōrum
415 et documenta damus, quā simus orīgine nātī.
Cētera dīversīs tellūs animālia formīs
sponte suā peperit, postquam vetus umor ab igne
percaluit sōlis caenumque ūdaeque palūdes
intumuēre aestū fēcundaque sēmina rērum
420 vīvācī nutrīta solō ceu matris in alvō
crēvērunt faciemque aliquam cēpēre morando.
Sīc ubi dēseruit madidōs septemfluus agrōs
Nīlus et antiquō sua flūmina reddidit alveō
aetheriōque recens exarsit sīdere līmus,
425 plūrima cultorēs versīs animalia glaebis
inveniunt et in hīs quaedam inperfecta suīsque
trunca vident numeris, et eōdem in corpore saepe
altera pars vīvit, rudis est pars altera tellūs.
430 Quippe ubi temperiem sumpsēre umorque calorque,
concipiunt, et ab hīs oriuntur cuncta duōbus,
cumque sit ignis aquae pugnax, vapor hūmidus omnēs
rēs creat, et discors concōrdia fetibus apta est.

Traduzione
Giove stava già per scagliare i suoi fulmini su tutte le terre, quando ebbe il timore che il sacro etere potesse incendiarsi per le enormi fiamme e che l’asse del mondo potesse continuare ad ardere a lungo. Si ricordò anche della profezia secondo la quale ci sarebbe stato un tempo in cui il mare e la terra e il regno celeste sarebbero stati completamente arsi dalle fiamme e l’intero cosmo, in difficoltà, ne avrebbe sofferto. Furono quindi riposti i dardi fabbricati per mano dei Ciclopi e piacque a Giove una pena diversa: il genere mortale sarebbe perito sotto le onde: fu cosí che nubi tempestose incombettero dal cielo.
Rinchiuse quindi subito nelle caverne eolie l’Aquilone e tutti quei venti che disperdono le nuvole e invece liberò il Noto: questi si levò in volo con le ali inzuppate e con lo spaventoso volto tinto di caligine nera come la pece: la barba, greve per i pesanti nembi, scorreva come un’onda di candidi capelli, sulla fronte dimoravano le nebbie, mentre le penne e le pieghe delle vesti grondavano d’acqua; quando con la mano estesa spremeva le nuvole pesanti, si generava un tuono: da cui si spandevano dall’etere le fitte burrasche.
Iride, la messaggera di Giunone, vestita di molti colori, raccoglieva le acque e alimentava le nubi: venivano distrutti i campi che poi giacevano desolati, compianti dai contadini, e si perse cosí inutilmente la fatica di un lungo anno di lavoro.
Né l’ira di Giove si limitò solo al cielo, ma il fratello ceruleo lo aiutò con l’ausilio delle onde. Cosí Nettuno convocò i corsi d’acqua e appena quando questi raggiunsero le dimore del loro Signore, egli disse: “non è necessario un comando complicato: serve che scateniate le vostre forze”. Ordinò: “Aprite le vostre case e con un’immensa mole alimentate i vostri fiumi a briglia sciolta.” I corsi d’acqua tornarono e rilasciarono acqua alle fonti e in maniera sfrenata si versavano nel mare. Nettuno percosse la terra con il suo tridente e quella tremò lasciando scoperte le vie al moto delle acque. I fiumi, sparsi in ogni direzione, scorrevano sui vasti campi trascinando in qualche modo con sé alberi, bestiame, persone, case e templi con i loro arredi sacri. L’onda poi sommerse ciò che non era ancora stato distrutto, anche le sommità più alte, e le torri pressate dalla forza delle acque scomparvero tra i flutti. Ormai non era più possibile distinguere la terra dal mare, poiché tutto era mare e non si potevano scorgere nemmeno le coste.
Qualcuno cercava scampo su un colle, qualcun altro si sedeva su una barca ricurva e remando si recava là dove aveva appena arato; un altro navigava sopra i campi seminati o sopra il tetto della sua casa ormai sommersa, un altro raccoglieva un pesce dalla cima di un olmo; per caso accadeva che si gettasse l’ancora su un verde prato o che gli scafi ricurvi sfregassero contro i vigneti sommersi, e laddove le gracili capre poco prima stavano pascolando, adesso le foche adagiavano i loro corpi deformi. Le Nereidi si meravigliavano scorgendo sott’acqua boschi, città e case, i delfini occupavano i boschi e urtavano contro i rami più alti, scuotendoli vivacemente con forza. Nuotava il lupo tra le pecore e l’onda si portava via i fulvi leoni, cosí come le tigri, né le forze fulminanti giovavano al cinghiale, né le zampe veloci aiutavano il cervo trascinato via dalla corrente, e gli uccelli si lasciavano cadere in volo, ormai esausti per aver cercato a lungo invano un pezzo di terra dove posarsi. L’immensa distesa marina inondava le alture e nuovi flutti si abbattevano sulle cime dei monti. La maggior parte degli esseri viventi morí tra le onde: chi ne fu risparmiato fu piegato da un lungo digiuno per la mancanza di cibo.
La Focide, che quando non era ancora sommersa era una terra feconda, separa l’Aonia dalla regione dell’Eta, e ormai era parte della distesa marina; là un monte scosceso di nome Parnaso tende agli astri con due cime, che superano le nuvole: non appena Deucalione con sua moglie, portato da una piccola zattera, si ancorò lì con una cordicella (infatti il mare ricopriva ogni altra cosa), eseguí un rituale di adorazione per le ninfe coricie, per i numi dei monti e per la dea profetica Temi, che allora dispensava oracoli: non esisteva nessuno migliore di lui o più amante della giustizia né nessuna che più di lei avesse rispetto verso gli Dei.
Giove, quando vide che il mondo ristagnava di paludi e che era sopravvissuto un solo uomo tra tante migliaia e una sola donna tra tante migliaia, entrambi onesti, entrambi adoratori degli Dei, sparpagliò le nuvole e dopo aver allontanato le tempeste, con il vento Aquilone, rese visibili le terre al cielo e il cielo alle terre. L’ira del mare terminò, e deposto il tridente il re del mare calmò le acque e convocò in superficie dagli abissi il ceruleo Tritone con le spalle coperte da conchiglie cresciutegli addosso e gli ordinò di soffiare nella conchiglia e di richiamare i flutti e fiumi con il segnale convenuto: egli afferrò la concava e ritorta buccina. Essa cresceva dal fondale come un grande vortice e quando risuonava in mezzo al mare, con il suo suono riempiva i litorali che si trovavano in ambo le direzioni del Sole. E anche quella volta, quando la bocca del Dio bagnata dalla barba madida, la prese e quando la tromba ricevette il soffio e suonò gli ordini di rientro, essa fu udita da tutte le onde sulla terra e sul mare, e placò tutte le onde dalle quali era stata udita. Già riappariva la costa accanto al mare, i corsi contenevano le masse d’acqua, i fiumi si ritiravano, si vedevano emergere le colline, comparve il terreno, si estese la terraferma mentre si restrinsero i mari, e dopo un lungo giorno i boschi mostravano le cime scoperte degli alberi, trattenendo il fango con le fronde.
La terra era stata salvata, ma Deucalione vide che era vuota e che un assoluto silenzio regnava sulle lande desolate, e quindi si rivolse a Pirra in lacrime:
“O sorella, o sposa, o unica superstite tra le donne, che sei stata unita a me dalla stessa gente, dalle stesse origini paterne, e poi dal matrimonio, ora invece sono i pericoli che ci uniscono, perché in tutta la terra, da oriente a occidente, ci siamo solo noi due, perché tutti gli altri sono scomparsi nel mare. Non mi sento nemmeno sicuro per le vite nostre perché ho ancora in me il terrore suscitato dalla tempesta. Cosa ne sarebbe stato di te se ti fossi salvata senza di me, come staresti stata, o infelice? Come avresti potuto affrontare la paura, completamente da sola? Come avresti consolato il tuo dolore? Infatti, credimi, se il mare avesse preso anche te, io ti avrei seguita, o sposa mia, e il mare avrebbe preso anche me. Oh, se almeno potessi ricreare i popoli con le arti paterne e infondere le anime ai corpi fatti di terra! Adesso il genere mortale è restato solo in noi due (cosí è sembrato opportuno agli Dei) e siamo i soli sopravvissuti di tutta l’umanità.
Cosí disse e intanto piangevano; poi decisero di pregare la divinità celeste e di chiedere aiuto con gli oracoli. Senza indugio andarono insieme tra le acque del fiume Cefiso, che ancora non era limpido ma che già scorreva arginato dal suo letto. Quindi, dopo aver asperso sulle vesti e sul capo l’acqua, si recarono al tempio della santa Dea; il frontone era livido di muschio ripugnante e gli altari erano privi di fuochi. Non appena toccarono i gradini del tempio, entrambi si prostrarono al suolo e con rispettuoso timore baciarono la gelida pietra e cosí dissero: “se è vero che gli Dei si fanno commuovere dai giusti, se è possibile smuovere l’ira degli Dei, dicci dea Temi, in che modo si può recuperare dalla rovina della nostra specie? Dea misericordiosa, prestaci il tuo aiuto perché tutto è stato sommerso”. La Dea si commosse e diede un oracolo: “Scendete dal tempio, velatevi il capo, slegate le cinture delle vesti e gettate dietro le spalle le ossa della Grande Madre”.
I due restarono a lungo stupiti. Ruppe per prima il silenzio Pirra e, rifiutandosi di obbedire alle istruzioni della Dea, si scusò e pregò con parole di sgomento, dicendo che aveva paura di offendere le ombre della Grande Madre gettando le ossa. Intanto continuavano fra sé a ripetersi le oscure parole dell’oracolo, senza capire, rimuginando. Quindi il figlio di Prometeo calmò con placide parole la figlia di Epimeteo e disse: “Quanto fallace è la nostra intelligenza, gli oracoli sono pietosi e non inducono mai al male, la Grande Madre è la terra: io credo che le pietre possano dirsi le ossa del corpo della terra. Ci è stato richiesto di gettare le pietre dietro la schiena.” Anche se Pirra rimase colpita dall’interpretazione del marito, in realtà nutriva poche speranze. La fiducia che entrambi avevano in questa indicazione divina era molto poca, ma che cosa avevano da perdere? Scesero dal tempio, si velarono il capo e sciolsero le tuniche e lanciarono le pietre dietro i loro passi come comandato. Le pietre (chi potrebbe crederlo, se non si prendessero gli antichi scritti come testimoni) cominciarono a perdere la loro durezza e ad ammorbidirsi, e alla fine a prendere forma. Presto, quando furono cresciute e intenerite, si cominciò ad intravedere una forma umana, molto simile a una rozza scultura, come se fosse stata abbozzata sul marmo, ma ancora non rifinita. Tuttavia una parte di loro restò umida e terrena con un po’ di liquido, e fu trasformata in membra; ciò che era invece solido e non poteva flettersi fu mutato in ossa; ciò che era la vena, restò sotto lo stesso nome; e in breve tempo per volontà divina i sassi gettati per mano dell’uomo assunsero un volto da uomo, mentre da quelli lanciati dalla donna si ricrearono donne. Quindi siamo una specie dura che prova fatica a testimonianza della nostra origine.
La Terra poi generò spontaneamente le altre forme di vita, e dopo che il sole ebbe riscaldato con il suo fuoco l’umidità già presente, le paludi bagnate fecero levitare il fango per il calore, i semi fecondi crebbero, nutriti dalla vitalità del terreno come se fossero nel ventre della madre, e cominciarono ad assumere vari aspetti, in modo simile a quando il Nilo dalle sette foci lascia i campi bagnati e fa rientrare i suoi fiumi nell’antico corso e il limo appena depositato si secca sotto l’astro etereo, e i contadini trovano tra le zolle arate molti animali, tra cui alcuni non completi e senza tutti gli arti, nello stesso animale una parte del corpo vive, mentre l’altra è fatta da terra grezza. Poiché quando l’umidità e il calore si sono miscelati, concepiscono, e da loro due nasce ogni cosa. Anche se il fuoco è contrario all’acqua, il vapore caldo e umido crea ogni cosa e la concordia degli opposti favorisce la procreazione.
Commento
Il diluvio di Ovidio è di rara bellezza, offrendo descrizioni e scenari drammatici, accompagnati dal ritmo degli esametri che ora accelera, ora rallenta, quasi ricalcando il moto ondoso, alternando in maniera esperta dattili e spondei. Non mi soffermerò comunque sui dettagli del sinistro Noto, o della buccina di Tritone simile a un gorgo, dove rimando piuttosto alla traduzione o al testo originale, ma cercherò di andare al nocciolo del messaggio teologico e filosofico.
Comprendere il diluvio non è semplice. La testimonianza più antica tramandataci dal mondo classico procede da Pindaro (VI-V secolo a.e.v.). Molte antiche tradizioni riportano con loro mitologie questo cataclisma preistorico, basti pensare all’epopea di Gilgamesh dei Sumèri, ripresa dalla Torah ebraica, o al mito di Manu dei testi vedici. Tuttavia, una ricerca del reale fenomeno meteorologico, per mezzo di una comparazione delle varie narrazioni, sacrifica le peculiarità di ogni singola tradizione. Effettivamente, ogni popolo interpreta un fatto secondo le proprie inclinazioni culturali, religiose e filosofiche, ed è proprio la speciale elaborazione del racconto che rivela il paradigma di partenza. La narrazione del diluvio si trasforma così in un contenitore dove diversi popoli hanno espresso le loro proprie concezioni del cosmo e del rapporto con la divinità. Il diluvio ne “Le Metamorfosi” ci offre quindi uno spaccato del pensiero greco-romano.
Leggendo la vivace descrizione di Ovidio, si capisce che la causa scatenante del diluvio è cancellare la razza umana a causa dell’abbandono della virtus, ossia dell’empietà. Ciò non è per niente banale: leggiamo le fantastiche descrizioni del testo che offrono una sceneggiatura che potrebbe essere utilizzata per un film di fantascienza fino ai dettagli, non solo nella descrizione delle nuvole, ma anche del tizio che rema sopra casa sua, o della barca che struscia lo scafo contro il fondale fatto da vigne, o della lenta e orribile morte per mancanza di cibo, o degli uccelli esausti che si lasciano cadere tra i flutti. Tutto ciò non è un’allegoria, non è un simbolo, ma una situazione reale nel mondo reale. Si muore. Ma a differenza di un film di fantascienza, la causa non è un asteroide o un attacco di alieni spietati. La causa è l’allontanamento dalla virtus, che ha indotto Giove a scatenare le intemperie.
I fatti del diluvio quindi riguardano un legame molto stretto tra mondo materiale e virtus, legame che merita essere approfondito. In primo luogo si descrive un universo privo di dualismo, condiviso da Dei e umani: non esiste un mondo spirituale ed uno materiale, bensì si condivide la stessa dimensione, benché in luoghi diversi. Da cui sorge la prudenza di Giove e la conseguente decisione di non scagliare i fulmini, per evitare che le fiamme possano far ardere anche l’etere e far ripiombare tutto in una specie di anticreazione, distruggendo il cosmo e lasciando la vittoria alle forze oscure del caos. Giove non ha l’intenzione di causare una fine del mondo con un’azione caotica usando il fuoco e dando origine a una conflagrazione cosmica, ma esercita la Sua azione usando solo due elementi (acqua e aria), escludendo il terzo (fuoco) per fermare la spirale di empietà che sta trascinando la terra verso il caos e riscrivere una nuova storia, in altre parole per fare tabula rasa e ripartire in direzione dell’ordine. Ricordiamo come nella sezione anteriore si narri del pericolo che gli uomini possano nuocere ai Semidei e alle altre creature divine. Inoltre, la conferma che il diluvio non rappresenti un ritorno al caos ma un avanzamento verso un nuovo ordine trova luogo nella promessa di una nuova umanità fatta da Giove all’assemblea divina.
Il nesso tra mondo, ordine e virtù è spiegato dalla filosofia stoica che, non a caso, offriva una grande fondazione etica all’azione riformatrice di Augusto e degli imperatori che seguirono. La materia di cui tutto è fatto, anime e Dei compresi, è permeata dal logos, che è preposto alla funzione ordinatrice. Ciascuno di noi ha dentro di sé una parte di logos necessaria per la comprensione logica del mondo. Grazie a questa componente abbiamo un senso innato di giustizia e viviamo un’esistenza etica. Da cui la virtus altro non è che l’azione ordinatrice dell’individuo nel mondo e nella società, così come nell’impero, nella naturale direzione del logos. La virtus è il mezzo con il quale partecipiamo all’ordinamento logico del cosmo. Ma nella comprensione stoica, dove tutto è materiale, la virtù diventa l’ossatura tangibile della realtà, il suo ordine. Lo stoicismo quindi non propone il materialismo in senso moderno, ma una spiritualità materiale. Nel momento in cui gli esseri umani si allontanano dalla virtù, viene meno l’ordine cosmico e l’universo ne risente. Oggi potremmo obiettare che questa visione sia antropocentrica, tuttavia, considerato che Giove, senza troppi complimenti, stermina l’antica popolazione, sarebbe probabilmente più corretto considerarla logocentrica piuttosto che antropocentrica. Infatti, quando viene meno la risposta al logos – da parte degli animali logici – allora il cosmo ne risente.
Guardiamoci attorno. Il nostro mondo è malato. Non è per proporre un ambientalismo spicciolo, ma è un dato di fatto, dimostrato dalla ricerca scientifica e dalla visione logica della realtà. Non abbiamo mai avuto in passato tanta tecnologia, tanta conoscenza, tanta potenza nelle nostre mani come oggi, eppure non sappiamo fermare la rovina che ci circonda. Infatti, non è la scienza che ci manca, ma l’etica. Siamo diventati sordi al logos e come risultato il nostro mondo ne risente e gli animali si estinguono perché, come nella descrizione di Ovidio, la casa è una sola, in comune con la natura e con gli Dei.
Un uomo e una donna sono i soli sopravvissuti tra le acque. Deucalione e Pirra, irreprensibili e giusti, dopo aver pianto davanti all’enorme disastro, decidono di purificarsi e di recarsi al diroccato tempio della dea Temi, dove non a caso hanno trovato la salvezza. Infatti la Dea della Giustizia non rappresenta le leggi scritte dagli uomini, ma qualcosa di molto più sacro: il logos, la giustizia insita nell’ordine naturale, la quale sa vedere anche le intenzioni degli esseri logici e quindi si lascia commuovere dalle preghiere degli onesti.
La via della salvezza è comunicata da Temi ai due superstiti con un oracolo, non con un ordine chiaro. L’oracolo richiede appunto il logos per la sua comprensione, non una cieca illogica fede. Deucalione e Pirra devono rimuginare a lungo e alla fine si servono della conoscenza del divino e del ragionamento per trovare la risposta, perché gli oracoli sono pietosi e non inducono mai al male (pia sunt nullumque nefās ōrācula suādent), e senza convinzione, mossi dal fatto che non avevano nulla da perdere (sed quid temptāre nocēbit?) eseguono quando indicato, gettandosi alle spalle pietre che si trasformano in nuove genti: nelle versioni greche del mito sussisteva il gioco di parole tra pietra (λᾶας) e popolo (λαός). Noi, uomini e donne, siamo fatti di fango e pietra, plasmati come opere d’arte per mezzo di una provvidenza miracolosa insita nella natura che agisce come uno scultore davanti al suo blocco di marmo: questa probabilmente è la metamorfosi più grande di tutta l’opera di Ovidio.
Anche gli animali devono essere rigenerati: segue una descrizione scientifica, basata sulle teorie esposte da Lucrezio, sulla formazione della vita dal caldo e dall’umido.
Il mondo era pronto per ripartire, ma nella rigenerazione si era annidato un mostro tremendo, il Pitone. Questa però è un’altra storia.
Mario Basile
(Fori Hadriani scripsit, Kal Sept. MMDCCLXXII)