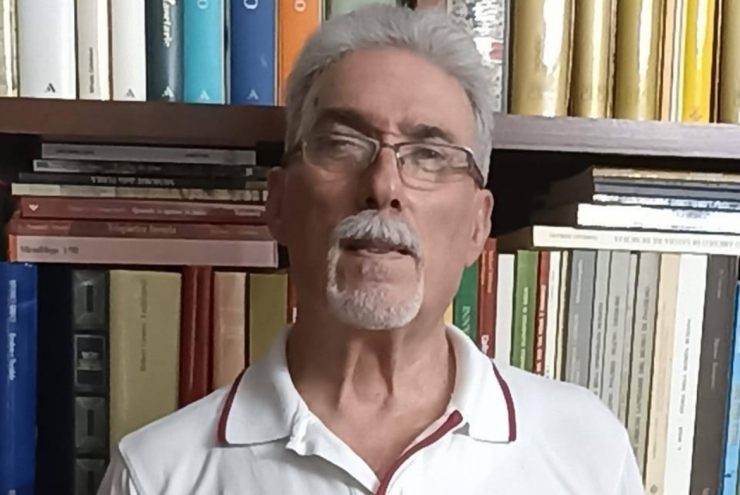Concludiamo con questo articolo la trattazione e il commento del Libro I de Le Metamorfosi di Ovidio, che abbiamo sviluppato per nove puntate su questa testata.
Le Metamorfosi di Ovidio. I, 568 – 779

I, 568 – xxx
- Est nemus Haemoniae, praerupta quod undique claudit
silva: vocant Tempē; per quae Pēnēos ab īmō
- effūsus Pindō spūmōsīs volvitur undīs
dēiectūque gravī tenuēs agitantia fūmōs
nūbila condūcit summīsque adspergine silvīs
inpluit et sonitū plus quam vīcīna fatīgat:
haec domus, haec sedes, haec sunt pēnetrālia magnī
- amnis, in hīs residens factō dē cautibus antrō,
undīs iūra dabat nymphīsque colentibus undās.
Cōnveniunt illūc populāria flūmina prīmum,
nescia, grātentur consōlenturne parentem,
pōpulifer Sperchīos et īnrequiētus Enīpeus
- Āpidanosque senex lēnīsque Amphrȳsos et Aeās,
moxque amnes aliī, quī, quā tulit inpetus illōs,
in mare dēdūcunt fessās errōribus undās.
Īnachus ūnus abēst īmōque reconditus antrō
flētibus auget aquās nātamque miserrimus Īō
- lūget ut āmissam: nescit, vītāne fruātur
an sit apud mānēs; sēd quam nōn invenit usquam,
esse putat nusquam atque animō peiōra verētur.
Vīderat ā patriō redeuntem Iuppiter illam
flūmine et ‘ō virgō Iove digna tuōque beātum
- nesciō quem factūra torō, pete’ dixerat ‘umbrās
altōrum nemorum’ (et nemorum monstrāverat umbrās)
‘dum calet, et mediō sōl ēst altissimus orbe!
quodsī sōla times latebrās intrāre ferārum,
praeside tūta deō nemorum secrēta subībis,
- nec dē plēbe deō, sēd quī caelestia magna
sceptra manū teneō, sēd quī vaga fulmina mittō.
Nē fuge mē!’ fugiēbat enim. Iam pascua Lernae
consitaque arboribus Lyrcēa relīquerat arva,
cum Deus inductā lātās cālīgine terrās
- occuluit tenuitque fugam rapuitque pudōrem.
Intereā mediōs Iūnō dēspexit in Argos
et noctis faciem nebulās fēcisse volucrēs
sub nitidō mīrāta diē, nōn flūminis illās
esse, nec ūmentī sensit tellūre remittī;
- atque suus coniunx ubi sit circumspicit, ut quae
dēprensī totiens iam nosset furta marītī.
quem postquam caelō nōn repperit, ‘aut ego fallor
aut ego laedor’ ait dēlapsaque ab aethere summō
constitit in terrīs nebulāsque recēdere iussit.
- cōniugis adventum praesenserat inque nitentem
Īnachidos vultus mūtāverat ille iuvencam;
bōs quoque formōsa ēst. Speciem Sāturnia vaccae,
quamquam invīta, probat nec nōn, et cūius et unde
quōve sit armentō, vērī quasi nescia quaerit.
- Iuppiter ē terrā genitam mentītur, ut auctor
dēsinat inquīrī: petit hanc Sātūrnia mūnus.
quid faciat? crūdēle suōs addīcere amōrēs,
nōn dare suspectum ēst: Pudor ēst, quī suādeat illinc,
hinc dissuādet Amor. victus Pudor esset Amōre,
- sēd leve sī mūnus sociae generisque torīque
vacca negārētur, poterat nōn vacca vidērī!
Paelice dōnātā nōn prōtinus exuit omnem
dīva metum timuitque Iovem et fuit anxia furtī,
dōnec Arestoridae servandam trādidit Argo.
- Centum lūminibus cinctum caput Argus habēbat
inde suīs vicibus capiēbant bīna quiētem,
cētera servabant atque in statiōne manēbant.
Constiterat quōcumque modō, spectābat ad Īō,
ante oculōs Īō, quamvīs āversus, habēbat
- lūce sinit pascī; cum sōl tellūre sub altā ēst,
claudit et indignō circumdat vincula collō.
Frondibus arboreīs et amārā pascitur herbā,
prōque torō terrae nōn semper grāmen habentī
incubat infelix līmōsaque flumina pōtat.
- Illa etiam supplex Argō cūm bracchia vellet
tendere, nōn habuit, quae bracchia tenderet Argō,
cōnātōque querī mūgītus ēdidit ōre
pertimuitque sonōs propriāque exterrita vōce est.
Vēnit et ad rīpās, ubi lūdere saepe solēbat,
- Īnachidās: rictus novaque ut conspexit in unda
cornua, pertimuit sēque exsternāta refūgit.
Naidēs ignōrant, ignōrat et Īnachus ipse,
quae sit; at illa patrem sequitur sequiturque sorōrēs
et patitur tangī sēque admīrantibus offert.
- Dēcerptās senior porrexerat Īnachus herbās:
illa manūs lambit patriīsque dat oscula palmīs
nēc retinet lacrimās et, sī modo verba sequantur
ōret opem nōmenque suum cāsusque loquātur;
littera prō verbīs, quam pēs in pulvere duxit,
- corporis indicium mūtātī triste perēgit.
‘Mē miserum!’ exclamat pater Īnachus inque gementis
cornibus et niveā pendens cervīce iuvencae
‘Mē miserum!’ ingeminat; ‘tūne es quaesīta per omnēs
nāta mihī terrās? tū nōn inventa reperta
- luctus erās levior! Reticēs nec mūtua nostrīs
dicta refers, altō tantum suspīria dūcis
pectore, quodque unum potes, ad mea verba remūgis!
at tibi ego ignārus thalamōs taedāsque parābam,
spesque fuit generī mihi prīma, secunda nepōtum.
- Dē grege nunc tibi vīr, nunc dē grege nātus habendus.
Nec fīnīre licet tantōs mihi morte dolōrēs;
sēd nocet esse deum, praeclūsaque iānua lētī
aetērnum nostrōs luctus extendit in aevum.’
Talia maerentī stellātus submovet Argus
665 ēreptamque patrī dīversa in pascua natam
abstrahit. ipse procul montis sublīme cacūmen
occupat, unde sedens partēs speculātur in omnēs.
Nec superum rector mala tanta Phorōnidos ultra
ferre potest nātumque vocat, quem lūcida partu
- Plēias ēnīxa est lētōque det imperat Argum.
Parva mora est ālās pedibus virgamque potenti
somniferam sumpsisse manū tegumenque capillīs.
Haec ubi disposuit, patriā Iove nātus ab arce
dēsilit in terrās; illic tegumenque remōvit
- et posuit pennās, tantummodo virga retenta est:
hāc agit, ut pastor, per dēvia rūra capellās
dum venit abductās, et structīs cantat avēnīs.
vōce novā captus custōs Iunōnius ‘at tū,
quisquis es, hōc poterās mēcum consīdere saxō’
- Argus ait; ‘neque enim pecorī fēcundior ullō
herba locō est, aptamque vidēs pastōribus umbram.’
Sēdit Atlantiadēs et euntem multa loquendō
dētinuit sermōne diem iunctisque canendō
vincere harundinibus servantia lūmina temptat.
- Ille tamen pugnat mollēs evincere somnōs
et, quamvis sopor est oculōrum parte recēptus,
parte tamen vigilat. Quaerit quoque (namque reperta
fistula nūper erat), quā sit ratione reperta.
Tum Deus ‘Arcadiae gelidis sub montibus’ inquit
- ‘inter hamādryadās celeberrima Nōnacrīnas
nāiās ūna fuit: nymphae Sȳringa vocābant.
Nōn semel et satyrōs ēlūserat illa sequentēs
et quōscumque deōs umbrōsaque silva feraxque
rūs habet. Ortygiam studiīs ipsāque colēbat
- virginitāte deam; rītū quoque cincta Diānae
falleret et posset crēdī Lātōnia, sī nōn
corneus huic arcus, sī nōn foret aureus illī;
sic quoque fallēbat. Redeuntem colle Lycaeō
Pan videt hanc pīnūque caput praecinctus acūtā
- tālia verba refert – restābat verba referre
et precibus sprētīs fugisse per āvia nympham,
dōnec harēnōsī placidum Ladōnis ad amnem
vēnerit; hīc illam cursum inpedientibus undīs
ut sē mūtārent liquidās ōrasse sorōrēs,
- Pānaque cum prensam sibi iam Sȳringa putāret,
corpore prō nymphae calamōs tenuisse palustrēs,
dumque ibi suspīrat, mōtōs in harundine ventōs
effēcisse sonum tenuem similemque querentī.
Arte novā vōcisque deum dulcēdine captum
710 ‘hōc mihi colloquium tēcum’ dixisse ‘manēbit,’
atque ita disparibus calamīs conpāgine cērae
inter sē iunctīs nōmen tenuisse puellae.
Tālia dictūrus vīdit Cyllēnius omnēs
subcubuisse oculōs adopertaque lūmina somnō;
715 supprimit extemplō vōcem firmatque soporem
languida permulcens medicātā lūmina virgā.
Nec mora, falcātō nūtantem vulnerat ense,
quā collō est confīne caput, saxōque cruentum
dēicit et maculat praeruptam sanguine rūpem.
720 Arge, iacēs, quodque in tot lūmina lūmen habēbās,
exstinctum est, centumque oculōs nox occupat ūna.
Excipit hōs volucrisque suae Sāturnia pennīs
collocat et gemmīs caudam stellantibus inplet.
Prōtinus exarsit nec tempora distulit īrae
725 horriferamque oculīs animōque obiēcit Erīnyn
paelicis Argolicae stimulōsque in pectore caecōs
condidit et profugam per tōtum exercuit orbem.
Ultimus inmensō restābās, Nīle, labōri;
quem simulac tetigit, positīsque in margine rīpae
730 prōcubuit genibus resupīnōque ardua collō,
quōs potuit sōlōs, tollens ad sīdera vultus
et gemitū et lacrimīs et luctīsōno mugītū
cum Iove vīsa querī fīnemque ōrāre malōrum.
Coniugis ille suae conplexus colla lacertīs,
735 fīniat ut poenās tandem, rogat ‘in’ que ‘futūrum
pōne metus’ inquit: ‘numquam tibi causa dolōris
haec erit,’ et Stygias iubet hōc audīre palūdes.
Ut lēnīta Dea est, vultus capit illa priōres
fitque, quod ante fuit: fugiunt ē corpore saetae,
740 cornua dēcrescunt, fit lūminis artior orbis,
contrahitur rictus, redeunt umerīque manusque,
ungulaque in quinōs dīlapsa absūmitur ungues:
dē bove nīl superest formae nisi candor in illā.
Officiōque pedum nymphē contenta duōrum
745 ērigitur metuitque loquī, nē mōre iuvencae
mūgiat, et timidē verba intermissa retemptat.
Nunc dea līnigerā colitur celeberrima turbā.
Huic Epaphus magnī genitus dē sēmine tandem
creditur esse Iovis perque urbēs iuncta parentī
750 templa tenet. Fuit huic animīs aequālis et annīs
Sōle satus Phaethōn, quem quondam magna loquentem
nec sibi cēdentem Phoebōque parente superbum
non tulit. Īnachides ‘matrī’ que ait ‘omnia dēmens
credis et es tumidus genitōris imāgine falsī.’
755 Erubuit Phaethōn īramque pudōre repressit
et tulit ad Clymenēn Epaphī convīcia matrem
‘quō’ que ‘magis doleās, genetrix’ ait, ‘ille ego līber,
ille ferox tacuī! pudet haec opprobria nōbīs
et dīcī potuisse et nōn potuisse refellī.
760 At tū, sī modo sum caelestī stirpe creātus,
ēde notam tantī generis mēque adsere caelō!’
dixit et inplicuit māternō bracchia collō
perque suum Meropisque caput taedasque sororum
traderet ōrāvit vērī sibi signa parentis.
765 Ambiguum Clymenē precibus Phaethontis an īrā
mōta magis dictī sibi crīminis utraque caelō
bracchia porrexit spectansque ad lūmina Sōlis
‘Per iubar hōc’ inquit ‘radiīs insigne coruscīs,
nāte, tibī iūrō, quod nōs auditque videtque,
770 hōc tē, quem spectās, hōc tē, quī temperat orbem,
Sōle satum; sī ficta loquor, neget ipse videndum
sē mihi, sitque oculis lux ista novissima nostris!
Nec longus labor est patrios tibi nosse penātēs.
Unde oritur, domus est terrae contermina nostrae:
775 sī modo fert animus, gradere et scītābere ab ipsō!’
Ēmicat extemplō laetus post tālia matris
dicta suae Phaethōn et concipit aethera mente
Aethiopāsque suōs positōsque sub ignibus Indōs
sīdereīs transit patriōsque adit inpiger ortus.

Traduzione
C’è un bosco in Tessaglia, chiamato il Tempe, completamente circondato da una selva impenetrabile, attraversato dal fiume Peneo che scorre con flutti spumeggianti dai piedi del monte Pindo. Il fiume, con un’imponente cascata, genera nuvole che sollevano vapori leggeri e bagna le cime degli alberi con l’umidità e domina con il suo fragore i luoghi vicini ed oltre. Questo bosco è la casa, la sede, il santuario di un grande fiume, che dimora in una grotta fatta di pietre spigolose, da dove signoreggia sulle ninfe che vivono tra le onde. Là si raccolgono inizialmente i fiumi del posto, non sapendo se congratularsi con il genitore o se consolarlo: lo Sperchio pieno di pioppi e l’irrequieto Enipeo, il vecchio Apidano ed il calmo Anfriso e l’Eante, e poi si radunano anche gli altri corsi d’acqua che fan scendere, per dove il loro slancio li porta, le onde fino al mare, ormai stanche di tanto errare.
Manca solo l’Ìnaco che, nascosto nel fondo di una grotta, sta alimentando le acque con le sue lacrime e disperato si addolora per la figlia Io scomparsa: non sa se sia viva o morta, ma poiché non la trova da nessuna parte, crede che che non ci sia più e si prepara al peggio. Giove, che l’aveva vista mentre lei ritornava al fiume paterno, le aveva detto:
“O vergine degna di Giove, che in matrimonio farai beato non so chi, entriamo insieme nelle ombre di quelle fitte selve (e indicava le ombre delle selve) finché fa caldo e il sole è molto alto nel cielo! Infatti, anche se hai paura di avvicinarti alle tane delle fiere, dentro la foresta sarai sicura, sotto la protezione di un dio, non di un dio qualunque, ma di me, che reggo con la mano lo scettro celeste e scaglio fulmini dovunque. Ma non scappare!” e invece lei si mise a correre.
Lei si era già lasciata alle spalle i pascoli di Lerna e i campi disseminati di alberi del Lirceo, quando il Dio coprì una vasta zona con la nebbia, fermò la sua fuga e le rapì la castità.
Nel frattempo Giunone scrutava dall’alto il centro della regione di Argo e, sorpresa che alcune nuvole avessero rapidamente rabbuiato la zona, durante un giorno sereno, comprese che quelle non provenivano dal fiume, né dall’umidità del suolo, ma si guardò intorno cercando il suo sposo, siccome già conosceva le infedeltà del marito, già colto tante volte in flagrante. E dopo averlo cercato senza trovarlo nei cieli, disse: “Mi sbaglio, o vuole tradirmi?” e, scesa dall’alto dell’etere, si fermò sulla terra e ordinò alle nuvole di ritirarsi. Ma Egli aveva presagito l’arrivo della moglie ed aveva trasformato l’aspetto della figlia di Inaco in una rigogliosa giovenca; Io, anche sotto le sembianze di una mucca, restava pur sempre bella. Giunone, figlia di Saturno, sebbene sforzandosi esaminò l’aspetto della mucca e, come se ignorasse la verità, chiese di chi fosse, da dove venisse e quale fosse il suo armento. Giove faceva finta di niente dicendo che la mucca era nata dalla terra, affinché si smettesse di investigarne la provenienza: allora la Saturnia la chiese in dono. Che cosa poteva fare Giove? Cedere il suo amore sarebbe stato crudele, ma non darlo avrebbe generato sospetto. Da una parte lo persuadeva il pudore, dall’altra l’amore. E il pudore sarebbe stato vinto dall’amore, ma se fosse stata negata la vacca come regalo ingannevole alla compagna di famiglia e di matrimonio, si sarebbe potuto capire che non si trattava di un animale! Ricevuta l’amante, la Dea non perse tutta la paura e temette che Giove potesse ancora rubargliela, e quindi la affidò in custodia al figlio di Arestore, Argo. Argo aveva la testa cinta di cento occhi, dei quali due alla volta si riposavano, mentre gli altri funzionavano restando vigili. In qualunque modo si mettesse, controllava Io, e anche se si voltava indietro aveva Io di fronte agli occhi. Di giorno le permetteva di pascolare; ma quando il sole tramontava, la rinchiudeva e le cingeva indegnamente il collo con una catena. L’infelice si nutriva di fronde d’alberi e di erba amara e invece di dormire su un letto, dormiva sulla terra che non sempre offriva un giaciglio d’erba, e beveva da fiumi limacciosi. E anche se avesse voluto tendere le braccia in supplica ad Argo, non avrebbe avuto braccia da tendergli, e quando provava a lamentarsi le usciva un muggito dalla bocca, e si terrorizzava con i suoni della propria voce. Si recò anche presso le rive dell’Ìnaco dove di solito giocava: quando scorse riflesso tra le onde il muso e le nuove corna, si spaventò e fuggì via sconvolta. Le Naiadi e lo stesso Inaco ignoravano la sua vera identità, ma lei continuava a seguire il padre e le sorelle e si lasciava toccare e si offriva alla loro ammirazione. Il vecchio Inaco le porse dell’erba raccolta e lei leccò la mano a suo padre e gli baciò le palme e non trattenne le lacrime e se solo fossero seguite le parole, avrebbe chiesto aiuto e rivelato il suo nome e la sua condizione; ma al posto delle parole le lettere, che scrisse sulla sabbia con la zampa, offrirono il triste indizio al padre che il suo corpo era stato mutato.
“Misero me!” esclamò il padre Inaco mentre abbracciava le corna ed il collo candido come la neve della giovenca gemente e continuava a lamentarsi:
“Misero me! Sei proprio tu la mia figliola che io ho cercato in ogni luogo? Sarebbe stato meglio se non ti avessi mai trovata, perché la mia sofferenza sarebbe stato più lieve! Taci e muta non mi rispondi quando parlo, ma solo fai profondi sospiri nel tuo petto e tutto ciò che puoi fare è muggire alle mie parole! Ma io ignaro ti preparavo il talamo e le nozze, sperando di avere prima un genero e poi dei nipoti. E invece adesso il tuo consorte proverrà da un gregge e dal gregge proverrà tuo figlio. Nemmeno con la morte può finire il mio dolore, essere un dio mi nuoce, poiché essendomi preclusa la soglia della morte, il mio strazio si prolungherà in eterno.”
Mentre il padre piangeva in questa maniera, Argo dagli occhi scintillanti lo allontanava strappandogli via la figlia e trascinandogliela lontano verso altri pascoli. Quindi Argo si mise in cima alla vetta di un monte, da dove sedendo poteva guardare ovunque. Ma il Re degli Dei non poteva più tollerare tanto male per Io, parente di Foroneo, e chiamò Mercurio, il figlio che la luminosa Pleiade gli aveva partorito, ordinandogli di uccidere Argo. Poco dopo Mercurio con le ali ai piedi aveva già preso in mano la bacchetta che causava il sonno e si era messo l’elmo sui capelli. Non appena si fu preparato in questo modo, saltò giù dalla rocca paterna verso la terra; là si tolse l’elmo e depose le ali, tenendo con sé solo la bacchetta: quindi con questa, simile a un pastore, si mise a condurre alcune caprette rubate, mentre procedeva lungo la campagna remota, e intanto suonava una zampogna di canne intagliate. Argo, il guardiano di Giunone, affascinato dal nuovo suono, gli disse:
“Ehi tu, chiunque tu sia, potresti sederti con me su questo sasso? Infatti non c’è nessun altro luogo dove erba sia più feconda di questa e dove l’ombra sia più adatta ai pastori”.
Si sedette il figlio di Atlante e parlando a lungo lo intrattenne tutta la giornata mentre suonava la zampogna, cercando di vincere i suoi occhi vigilanti. Ma Argo continuava a combattere contro il dolce sonno e, per quanto il sopore gli avesse conquistato una parte degli occhi, l’altra parte tuttavia continuava a vegliare. Allora Argo gli chiese come fosse stata inventata la zampogna, che infatti allora era un’invenzione recente. E allora il Dio rispose:
«Sotto i gelidi monti dell’Arcadia, tra le Amadriadi di Nonacre, ci fu una sola naiade famosissima: le ninfe la chiamavano Siringa. Era riuscita a scappare dai satiri più di una volta mentre la seguivano e anche da tutti gli Dei e da chi viveva nella selva ombrosa e nella campagna fertile. Venerava Diana, la dea Ortigia, mantenendo come Lei la verginità; e si vestiva proprio come Diana tanto che si poteva confonderla con la Latonia, se non fosse stato per il suo arco di corno invece che d’oro, ma anche così traeva in inganno. Un giorno, mentre ritornava dal colle Liceo, Pan con la testa cinta di aghi di pino la vide e le parlò – e non gli restò altro da fare che raccontare come la ninfa, disprezzate le sue suppliche, fosse fuggita per luoghi inaccessibili, fino a raggiungere il placido corso del sabbioso Ladone; ma là, poiché il fiume le impediva il continuare la fuga, lei pregò le sorelle d’acqua di trasformarla, e quando ormai Pan credeva di averla stretta a sé, invece del corpo della ninfa si trovò ad abbracciare delle canne palustri e quindi si mise a sospirare, ma il suo soffio sulle canne aveva generato un suono dolce, simile a un gemito. Il Dio, catturato dalla dolcezza del tono della nuova scoperta esclamò: “In questo modo potrò sempre parlarti” e così diede il nome della ragazza allo strumento fatto di canne di lunghezza diversa tenute insieme da un po’ di cera.»
Mentre stava raccontando tutto ciò Mercurio, il Dio di Cillene, s’accorse che gli occhi di Argo avevano ceduto e si erano chiusi tutti per il sonno; smise quindi immediatamente di parlare e sigillò il sonno agli occhi languidi con la sua verga magica. Mentre Argo vacillava, lo colpì senza indugio con la spada arcuata, là dove la testa si unisce al collo, e lo gettò giù dalla rupe, tutto insanguinato, imbrattando l’impervia rocca. Ormai tu giacevi morto Argo, e quella luce che avevi in tutti i tuoi occhi si era spenta e una sola notte adesso occupava cento occhi. La Dea Saturnia, Giunone, li raccolse e li collocò sulle penne dell’uccello che le è sacro, ornandogli la coda con gemme scintillanti. La Dea quindi si accese d’ira e senza indugio scagliò l’orrida Erinni sugli occhi e sul cuore della rivale argolica e le conficcò nel petto un cieco terrore, tormentandola per tutta la terra. E tu, Nilo, restavi come ultima risorsa per questa sofferenza; non appena Io vi giunse, si inginocchiò sul margine della riva tendendo a fatica il collo in alto, così come poteva, alzando lo sguardo alle stelle sembrava rivolgersi a Giove con gemiti e lacrime e lugubri muggiti per supplicare la fine dei suoi mali. Giove allora gettando le braccia al collo della consorte la pregò di far finire la punizione e le disse:
“Non temere più per il nostro futuro: non ti sarà mai più causato dolore” chiamando a testimonianza le paludi dello Stige. Non appena la Dea si placò, Io cominciò a riprendere l’aspetto che aveva prima: sparirono i peli dal corpo e le corna le si restrinsero, le si rimpicciolirono gli occhi e le si contrasse il muso, ritornarono le braccia e le mani, e gli zoccoli dividendosi in cinque parti si trasformarono in unghie: della forma bovina non restò nulla se non il suo candore. La ninfa, felice della funzione delle sue due gambe si alzò con paura di parlare, per il timore che le salisse un muggito come una giovenca, e timidamente provò a esprimere parole come un tempo.
Ancora oggi Io è celebrata come una dea molto popolare da una folla vestita di lino. In breve, si crede che da lei, fecondata dal seme del grande Giove, sia stato generato Epafo, al quale sono stati dedicati templi in varie città insieme alla madre. Fetonte, nato dal Sole, era pari a Lui nel valore e nell’età. Una volta Epafo non sopportò che Fetonte si desse tante arie di essergli superiore per avere Febo come padre. Il nipote di Inaco gli disse: “Stupido che credi a tutto ciò che ti dice tua madre e ti insuperbisci per un’idea sbagliata su tuo padre.” Fetonte arrossì e trattenne l’ira con vergogna e raccontò a Climene, sua madre, l’insulto di Epafo e le disse:
“Ti generi maggior dolore il fatto che io che sono schietto, io che sono orgoglioso, ho dovuto tacere! Mi vergogno che mi si sia potuto oltraggiare in questo modo e che non abbia potuto controbattere. Ma tu, se io veramente sono stato generato da stirpe celeste, manifesta una prova della mia nobile origine e accoglimi nel cielo!” e cinse le braccia al collo della madre e la pregò sulla sua testa e su quella di Merope, sulle nozze delle sorelle, di dargli un segno del suo vero padre. Climene, non si sa se mossa più dalle preghiere di Fetonte o piuttosto dall’ira dell’offesa arrecata, stese entrambe le braccia al cielo e guardando la luce del sole disse:
“Figlio mio, ti giuro su questo glorioso splendore di raggi abbaglianti, che ci ascolta e ci guarda, che tu sei figlio proprio del Sole che stai vedendo, proprio del Sole che scalda la terra. Se sto mentendo, che Lui mi neghi la vista e che questa sia l’ultima luce che vedo! E la tua sofferenza di non conoscere la casa paterna finirà presto. La terra dove tuo padre dimora e da dove egli sorge confina con la nostra: se hai coraggio, mettiti in marcia e chiedi a lui stesso.”
Immediatamente dopo quanto detto dalla madre Fetonte balzò felice e mentre immaginava l’etere con la fantasia, lasciata la sua terra di Etiopia, attraversò l’India sotto il calore dell’astro e raggiunse solerte il luogo da dove sorgeva suo padre.
Commento
Esiste l’ordine naturale, dove ognuno si sente sicuro nel suo ruolo, nella sua posizione, nelle regole. Noi umani siamo sempre alla ricerca di questo ordine, più o meno consapevolmente, a costo di autoimporci regole non scritte, come l’ora in cui andiamo a mangiare o a dormire, o il numero di cucchiaini di zucchero nel caffè, o la quantità di edulcorante, o qualunque delle nostre centinaia di piccole abitudini. Amiamo le regole, ci fanno muovere in armonia con gli altri, amiamo rifugiarci nella tiepida sicurezza della consuetudine. Da anni osservo come la sequenza di arrivo al posto di lavoro, anche quando ci sia un orario flessibile, è sempre la stessa, indipendentemente dal luogo. Quando dai un appuntamento a quattro amici, puoi prevedere con una buon livello di confidenza l’ordine d’arrivo, perché c’è quello che arriva sempre in anticipo, quello che arriva sempre puntuale, quello che arriva con cinque minuti di ritardo e quello che non riesce a fare a meno del suo quarto d’ora accademico. In famiglia, le consuetudini diventano il telaio su cui si dipana la nostra esistenza, cercando di mettere barriere contro cambi non desiderati. Ordine naturale, appunto, con le sue consuetudini sociali e anche religiose. Nessuno ci obbliga a compiere un rituale, ma la ricerca dell’armonia cosmica e della Pax Deorum semplicemente ci è conforme, naturale, innata, cosí come la periodica scansione del calendario, con le sue feste e le sue stagioni.
Sembrerebbe che il ciclico ripetersi di azioni e situazioni ci metta in sintonia con il concetto di stabilità ed eternità. In fondo, la continuazione di una tradizione, o di una festività nel calendario, trascende la nostra stessa esistenza terrena, fornendoci il pretesto per ampliare il nostro orizzonte temporale.
Tuttavia questo trama di regolarità non conclude l’orizzonte delle nostre vite, né l’orizzonte cosmico. C’è un grande impulso del cambiamento, spesso creativo, che è presente in ogni cosa. Sulla ciclicità del calendario si sviluppa una dinamica di eventi irrepetibili: la storia. A livello cosmico, la potenza che induce l’esplosione ed emanazione dell’universo dall’unicità trascendente, lungo il senso definito dall’entropia crescente, è impersonata dalla forza travolgente di Amore, a cui nulla resiste, né animali, né umani, né Dei. È Amore il motore incontrastato dei cambiamenti, delle metamorfosi, libero da ogni calcolo, sovversivo, antisistema, caotico. L’imprevisto che ha cambiato i piani di generazioni. Amore, che per i Romani era tanto corteggiamento come passione amorosa dirompente, libidine cosmica. Il copione ripetuto varie volte da Ovidio è quello di una donna o una ninfa, che vuole resistere alla forza cosmica, votandosi alla verginità, rifiutando ogni uomo, e finendo così ad attirare le attenzioni di un Dio, con una legge da contrappasso: Apollo con Dafne e Pan con Siringa. Nel caso di Io non appare questa propensione alla verginità, considerato che il padre aveva altri piani per lei. Se da una parte fanciulle e ninfe sono trasformate in animali ed alberi, dall’altra anche gli Dei ne risentono delle conseguenze, seppur in forma meno drammatica ma altrettanto profonda. Apollo adotta l’alloro come suo simbolo, ossia come parte della sua stessa essenza. Giove stesso si trasforma in vari animali per assecondare l’impulso di Amore.
Noi, lettori di Ovidio, non ne siamo immuni, si tratta solo di riconoscerlo. Quante trasformazioni abbiamo affrontato nella nostra vita in seguito al caotico intervento di Amore? L’incontro rompe l’equilibrio delle nostre vite e stravolge l’ordine anteriore, la routine, frammentando la nostra esistenza con una sequenza di “prima” e di “dopo”, capitomboli e piroette, commedie e tragedie, gelosie e passioni folli, fatti divertenti e avventati, nuovi ambienti, nuovi giri, spesso nuove città, nuove regioni, nuovi paesi. All’inizio di una storia amorosa si prova quel senso di vertigine delle cose che realmente succedono, o contro voglia, sopportandone le conseguenze amare, oppure ci caricano dell’illusione di cavalcare la poderosa onda degli eventi, con una tavoletta da surf in equilibrio precario. Sono i momenti in cui avvertiamo l’accelerazione delle metamorfosi nelle nostre vite.
La forza di Amore non si limita alla passionalità umana, al nostro ambito psicologico e sociale, ma affonda le radici nel processo stesso dell’esistenza del cosmo, secondo la metafisica neoplatonica. La causa prima del cosmo, per definizione, è l’Uno, puramente trascendente, non partecipabile, che non è il “Creatore”, altrimenti sarebbe direttamente conoscibile attraverso la sua opera (ricordiamo la polemica tra Porfirio ed i cristiani). L’Uno è caratterizzato contemporaneamente dalla propria esistenza e dalla propria energia. La sua esistenza è il Principio del Limite, che fornisce a ogni ente la sua definizione, stabilità, limite ed identità. La sua energia è il Principio dell’Illimitato, il principio d’espansione senza limite, la potenza che si può trasferire legando tutto il cosmo. Questi due principi sono la causa di ogni definizione e mutamento nell’universo e si propagano dall’unità trascendente ad ogni livello d’esistenza, manifestandosi come caratteristica anche negli Dei e nelle Dee. In questa chiave di lettura metafisica, Giove impersonifica la propagazione della potenza creatrice che continuerebbe illimitata, mentre Giunone rappresenta il principio del limite.
Questi due principi filosofici neoplatonici, mentre si scontrano con lo statico creazionismo delle religioni monoteistiche, trovano riscontro nell’evoluzionismo di Darwin. La moltiplicazione e la differenziazione che tuttavia non è cieca ma bilanciata da regole. Infatti, nonostante questo motore di continua differenziazione, non vediamo attorno a noi un continuum di esseri viventi indefiniti, mutazioni di mutazioni, ma per ogni essere vivente identifichiamo chiaramente ordine, famiglia, genere e specie.
Tuttavia, Ovidio ci ammonisce, a volte qualcosa succede e si perde l’equilibrio. Quando l’azione creatrice non è bilanciata dalla funzione del limite, si generano forme di vita nuove, mutazioni che possono essere mostruose, di cui l’ultimo virus letale apparso in questa pandemia può essere inteso come un esempio. La propagazione del virus, secondo il principio dell’illimite, deve essere arrestata con il contenimento, principio del limite.
Ovviamente l’equilibrio vale nelle due direzioni: se invece prendesse sopravvento il principio del limite su quello dell’illimite, la vita ristagnerebbe, non ci sarebbe più procreazione e le specie potrebbero andare incontro all’estinzione. In questo senso la mitologia mostra il delicato equilibrio tra definizione e azione, che forma una struttura per la vita stessa e l’intero universo.
La narrazione della metamorfosi di Io si dipana in maniera complessa. Il tema è introdotto da una prospettiva obliqua, con l’assenza di Inaco dall’incontro con gli altri fiumi. Inaco piange dentro la sua grotta per la scomparsa di sua figlia, di cui non sa nulla, ma noi veniamo informati che la ninfa è stata trasformata in una mucca da Giove. Probabilmente si trattava di una mutazione temporanea, ma l’intervento di Giunone, che vigila sullo Status Quo del cosmo, porta ad una situazione di stallo, proprio secondo il concetto di limite, sigillato da Argo, come garanzia del non ritorno. La trasformazione è atroce. Come nel caso di Licaone, visto qualche capitolo fa, la vittima soffre per l’impossibilità di parlare. L’orrore si amplifica perché Io resta sempre cosciente, dell’erba amara che mangia, dell’acqua limacciosa che beve, dei suoi muggiti, così cupi eppur muti. La parte umana, che continua a darle coscienza e a farla soffrire, la spinge a scrivere con le zampe sul terreno per farsi riconoscere dal padre, prima di essere trascinata via da Argo.
Ovidio, con genialità, rallenta la narrazione inserendo il mito di Siringa, che pur riprendendo il tema delle trasformazioni dovute all’amore, sembra quasi un’intervallo rispetto alla tensione drammatica della vicenda di Io. Ma quando gli occhi di Argo si chiudono e noi ormai ci siamo distratti e rilassati nell’ombra assieme al pastore che suona la zampogna, all’improvviso un colpo di spada insanguina la scena, come in un film di Tarantino, accelerando gli eventi.
Ci sono pochi casi nella mitologia in cui una metamorfosi viene invertita: il più noto è l’episodio di Ulisse e la maga Circe. Anche in quel caso il dio Mercurio intervenne a favore di chi subiva la metamorfosi. Qui il Dio spezza la barriera del limite imposto da Giunone per favorire il ritorno dell’essere ad uno stato superiore, da animale ad umano, una funzione ben conosciuta di Mercurio. L’intervento in questo caso è solo un primo ma fondamentale passo per la liberazione di Io dalla sua metamorfosi. L’uccisione di Argo induce all’apice della crisi, dove la stremata Io, tormentata da Giunone, si inginocchia sulle rive del Nilo, essendo lei figlia di un fiume, ed allunga il collo al cielo (altro aspetto umano). Giove dunque s’impietosisce e ristabilisce l’ordine cosmico con la sua consorte: non appena si placa l’ira di Giunone, ossia non appena si ristabilisce la Pace degli Dei, Io riprende le sue sembianze umane, regalandoci un lieto fine.
Io non è una figura mitologica di secondo piano. La vacca è un simbolo lunare e l’identificazione di Io con la dea Iside, spesso raffigurata come una vacca bianca, offre quindi un ponte verso la mitologia egizia ampliando l’orizzonte del mito in una prospettiva sincretista. Altre fonti ci raccontano di come Io, prima di giungere al Nilo, passò per il mar Ionio, che prese il suo nome da lei, e giunta in Egitto partorì il bue sacro Api, mentre lei ascendeva in cielo come vacca celeste. La misteriosa connessione tra l’acqua e la luna ci trasporta in un tempo arcaico, dove le Baccanti, invasate, erompevano gridando “Io, io!”, che vuol dire “evviva”, usanza che ritroviamo nel benaugurante “Io Saturnalia”. La storia di Io si intreccia in un contesto mondiale della Grande Madre e Vacca Sacra, con Kalì-ma, Iside-Hathor e Brigid. Aprendo la narrazione su un piano che va ben oltre i confini dell’impero, Ovidio comincia a raccontare la storia di Fetonte, del suo viaggio dall’Etiopia verso l’India e oltre. Ma per questa storia dovremo aspettare il secondo libro.
Mario Basile
Fori Hadriani scripsit, Prid. Id Apr. MMDCCLXXIII [CEREALIA]