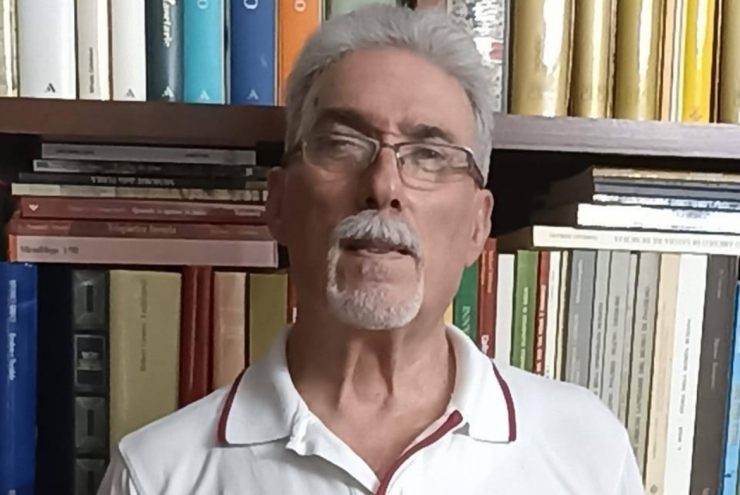Le Metamorfosi di Ovidio (I, 151-252): Giove-Augusto schianta Licaone e l’Età dei perversi

I, 151-252
- Nēve foret terrīs sēcūrior arduus aether,
adfectasse ferunt regnum caeleste Gigantās
altaque congestōs struxisse ad sīdera montēs.
Tum pater omnipotens missō perfrēgit Olympum
- fulmine et excussit subiectae Pēlion Ossae;
obruta mole suā cum corpora dīra iacērent,
perfūsam multō natōrum sanguinem Terram
inmaduisse ferunt calidumque animasse cruōrem
et, nē nulla suae stirpis monimenta manērent,
160.in faciem vertisse hominum. Sed et illa propāgo
contemptrix superum saevaeque avidissima caedis
et violenta fuit: scirēs ē sanguine nātōs.
Quae pater ut summā vīdit Saturnius arce,
ingemit et factō nondum vulgata recenti
165.foeda Lycāoniae referens convīvia mensae
ingentēs animō et dignās Iove concipit īras
conciliumque vocat; tenuit mora nulla vocātōs.
Est via sublīmis caelō manifesta serēnō:
lactea nōmen habet candōre notābilis ipsō;
170.hāc iter est Superīs ad magnī tecta Tonantis
rēgālemque domum:dextrā laevāque deōrum
ātria nōbilium valvīs celebrāntur apertīs,
plebs habitat diversia locīs:hāc parte potentēs
caelicolae clarīque suōs posuēre penātēs;
175.hīc locus est, quem, sī verbīs audācia dētur,
haud timeam magnī dixisse Palātia caelī.
Ergo ubi marmoreō superī sēdēre recessū,
celsior ipse locō sceptrōque innixus eburnō
terrificam capitis concussit terque quaterque
- caesariem, cum quā terram, mare, sīdera mōvit;
tālibus inde modīs ora indignantia solvit:
“Nōn ego prō mundī regnō magis anxius illā
tempestāte fuī, quā centum quisque parābat
inicere anguipedum captīvō bracchia caelō.
- Nam quamquam ferum hostis erat, tamen illud ab ūnō
corpore et ex ūnā pendēbat orīgine bellum;
nunc mihi, quā tōtum Nēreus circumsonat orbem,
perdendum est mortāle genus: per flūmina iūrō
infera sub terrās Stygiō labentia lūcō,
- cuncta prius temptāta, sed inmedicābile corpus
ense recidentum est, nē pars sincēra trahātur.
Sunt mihi sēmideī, sunt, rustica nūmina, Nymphae
Faunīque, Satyrīque et monticolae Silvānī,
quōs, quoniam caelī nondum dignāmur honōre,
- quās dedimus certē terrās habitāre sināmus.
An satis, ō superī, tūtōs fore crēditis illōs,
cum mihi, quī fulmen, quī vōs habeōque regōque,
struxerit insidiās nōtus feritāte Lycāon!”
Confremuēre omnēs studiīsque ardentibus ausum
- tālia dēposcunt: sīc, cum manus impia saevit
Sanguine Caesareō Rōmānum extinguere nōmen,
attonitum tantō subitae terrōre ruīnae
hūmānum genus est tōtusque perhorruit orbis,
nec tibi grāta minus pietās, Augūste, tuōrum est,
- quam fuit illa Iovī. Quī postquam vōce manūque
murmura compressit, tenuēre silentia cunctī.
Substitit ut clāmor pressus gravitāte regēntis,
Iuppiter hōc iterum sermōne silentia rūpuit:
“Ille quidem poenās (cūram hanc dīmittite) solvit:
- quod tamen admissum, quae sit vindicta docēbō.
Contigerat nostrās infāmia temporis aurēs;
quam cupiens falsam summō dēlābor Olympō
et deus hūmānā lustrō sub imāgine terrās.
Longa mora est, quantum noxae sit ubīque repertum,
- ēnumerāre: minor fuit ipsa infāmia vērō.
Maenala transieram latebrīs horrenda ferārum
Et cum Cyllēnē gelidī pīnēta Lycaeī:
arcadis hinc sēdēs et inhospita tecta tyrannī
ingredior, traherent cum sēra crepuscula noctem.
- Signa dedī venisse deum, vulgusque precārī
coeperat: inrīdet prīmō pia vōta Lycāon,
mox ait “experiar, deus hīc, discrīmine apērtō,
an sit mortalis; nec erit dubitābile vērum.”
Nocte gravem somnō necopīnā perdere morte
- mē parat: haec illī placet experientia vērī.
Nec contentus eō est: missī dē gente Molossā
obsidis ūnīus iugulum mūcrōne resolvit
atque ita sēminecēs partim ferventibus artus
mollit aquīs, partim subiectō torruit ignī.
- Quod simul imposuit mensīs, ego vindice flammā
in dominō dignōs ēvertī tecta penātēs;
territus ipse fugit nactusque silentia rūris
exululat frustrāque loquī cōnātur; ab ipsō
colligit os rabiem solitaeque cupīdine caedis
- utitur in pecudēs et nunc quoque sanguine gaudet.
In villōs abeunt vestēs, in crūra lacertī:
fit lupus et veterīs servat vestīgia formae;
cānitiēs eadem est, eadem violentia vultūs,
īdem oculī lūcent, eadem feritātis imāgo est.
- Occidit ūna domus, sed nōn domus ūna perīre
digna fuit; quā terra patet, fera regnat Erīnys.
In facinus iurasse putēs; dent ōcius omnēs
quās meruēre patī, sic stat sententia, poenās.”
Dicta Iovis pars vōce probant stimulōsque frementī
- adiciunt, aliī partēs adsensibus inplent;
est tamen hūmānī generis iactūra dolōrī
omnibus, et, quae sit terrae mortālibus orbae
forma futūra, rogant, quis sit latūrus in ārās
tūra, ferīsne paret populandās trādere terrās.
- Tālia quaerentēs (sibi enim fore cētera cūrae)
rēs superum trepidāre vetat subolemque priōrī
dissimilem populō promittit orīgine mīrā.
Traduzione
Si narra che i Giganti, affinché neppure l’alto etere restasse un luogo più sicuro della terra, attaccarono il regno celeste e ammassarono le montagne una sopra l’altra verso le stelle nel cielo. Allora il padre onnipotente, scagliato un fulmine, abbatté il monte Olimpo e fece precipitare il Pelio dall’Ossa che lo portava; quando gli orrendi corpi dei Giganti furono ricoperti dalla loro stessa massa, si dice che la Terra coperta dal molto sangue dei figli suoi ne restò bagnata e diede vita a un caldo mare fatto di sangue e, affinché non ci si dimenticasse della sua stirpe, lo modellò a figura degli esseri umani. Ma anche quella generazione fu sprezzante degli Dei e avidissima di distruzioni scellerate e violente: era chiaro che quella stirpe fosse nata dal sangue.
Quando il Dio Padre figlio di Saturno vide tutto ciò dalla volta celeste, gemette e rievocando i ripugnanti banchetti di Licaone, non ancora divulgati essendo un fatto recente, provò nell’animo un enorme rabbia degna di Giove e convocò un concilio; nessun ritardo trattenne i convocati. Quando il cielo è sereno si manifesta una via sublime: il suo nome è “lattea” per il suo notabile candore. Attraverso di lei passa l’itinerario per gli Dei Superi alla dimora del grande Tonante, alla casa regale: a destra e a sinistra ci sono a porte aperte le sale abitate dagli Dei nobili, mentre la plebe vive in altri luoghi mentre per questa parte le divinità potenti e illustre stabilirono la loro dimora. Questo luogo è tale che, se si concede l’audacia dell’espressione, non credo di esagerare definendolo il Palatino dei cieli. Dunque, quando gli Dei furono seduti nella sala marmorea, Giove, da un luogo più elevato, appoggiato allo scettro d’avorio, scosse tre quattro volte la terrificante chioma del capo con cui muove la terra, il mare e gli astri; quindi in tal maniera proferì parole d’indignazione:
“Quando le braccia dei giganti dai piedi di serpente tentarono di attaccare il cielo, io non ero piú preoccupato per il regno del mondo di quanto lo sia oggi. Allora infatti, per quanto il nemico fosse feroce, la guerra dipendeva soltanto da una fazione e soltanto da una causa; ma adesso devo distruggere il genere mortale da tutta la terra che Nereo circonda con le acque: giuro sui fiumi infernali, che scorrono sotto terra nel bosco dello Stige, di aver già provato di tutto, ma adesso l’arto incurabile deve essere tagliato via, affinché la parte sana non ne sia contagiata. Io ho semidei, numi delle campagne, Ninfe, Fauni, Satiri e Silvani dei monti, ai quali dobbiamo permettere di vivere in sicurezza su terre assegnate, poiché ancora non consideriamo loro degni dell’onore dei cieli. Forse voi, o Dei Superni, credete che essi saranno abbastanza sicuri, considerando come Licaone, noto per la sua ferocia, ordì trame contro di me, che porto il fulmine e che vi preservo e reggo!”
Tutti mormorarono sdegnati e con brama ardente chiesero di punire chi avesse osato tanto. O Augusto, in quella situazione Giove ebbe in odio la misericordia non meno di quanto l’avesti in odio tu, quando una banda di scellerati tentò di distruggere il popolo romano spargendo il sangue di Cesare, lasciando il genere umano attonito da tanto terrore per l’improvvisa sciagura di cui tutto il mondo ne rimase inorridito. Dopo che Giove fece smorzare il mormorio con la voce e con la mano, tutti restarono in silenzio. Quando il rumore cessò, per la potente autorità del re, Giove ruppe di nuovo il silenzio con questo discorso:
“Non preoccupatevi di quel Licaone, perché già ha pagato la sua pena: tuttavia vi spiegherò che crimine ha commesso e quale ne sia la punizione. Era giunta alle mie orecchie la cattiva reputazione di quell’età del ferro; desiderando che fosse una falsità scesi dal sommo Olimpo, come un dio sotto spoglie umane girovagando sulla terra. Richiederebbe molto tempo enumerare quanti delitti abbia trovato: la cattiva reputazione di Licaone infatti era niente a confronto. Dopo aver attraversato il Menalo, spaventoso per le tane delle belve feroci e le gelide pinete del Liceo, entrai nella sede e nei palazzi inospitali del tiranno dell’Arcadia, mentre il crepuscolo della sera portava la notte. Avevo rivelato la mia identità divina e il popolo aveva cominciato a pregare, ma per primo Licaone irrise le pie preghiere e quindi disse: “Metterò alla prova questo dio, per dimostrare apertamente che è un mortale; la verità sarà inconfutabile.” Egli macchinò di uccidermi di notte nel sonno: questa fu la dimostrazione della verità che scelse. Né gli bastò: tagliò la gola a uno degli ostaggi mandati dai Molossi e bollì una parte degli arti ancora palpitanti nell’acqua bollente e ne arrostì una parte sul fuoco. Ma appena servì a tavola, io bruciai il palazzo con il fuoco vendicatore e rovesciai i penati degni di tale padrone di casa; egli fuggì in preda al terrore e raggiunta la campagna silenziosa incominciò a ululare e provò a parlare inutilmente; oggi la bocca stringe il suo stesso furore e usa la sua abituale brama di strage sul bestiame e ancora adesso gode del sangue. Le sue vesti si trasformano in pelo, le braccia in zampe: si trasforma in un lupo e mantiene la forma dei piedi; la canizie e la violenza del volto sono le stesse e brillano gli stessi occhi: ha lo stesso aspetto feroce. È caduta una sola casa, ma non era l’unica che meritava di finire. In tutta la terra domina la feroce Erinni. Verrebbe da credere che gli uomini abbiano congiurato nell’empietà; il mio verdetto è che siano dunque tutti condannati al più presto alla pena che si meritano”.
Alcuni Dei approvarono a voce alta il discorso di Giove e fremendo aggiunsero la loro foga, altri soltanto assentirono; tuttavia tutti soffrivano per il dolore della perdita del genere umano e si chiedevano quale sarebbe stato il futuro assetto della terra senza i mortali e chi avrebbe portato incenso agli altari e se Giove intendeva consegnare le terre alle belve affinché le devastassero. Giove ordinò gli Dei che si facevano queste domande di non preoccuparsi, dicendo che egli si sarebbe preso cura di ogni cosa e promise una nuova progenie di mirabile origine, diversa da quella precedente.

Commento
Questa lunga sezione del primo libro colpisce principalmente per due narrazioni che si sovrappongono. La prima è la spettacolare immagine dell’adunata divina dopo la chiamata di Giove, la seconda è il discorso di Giove, una colorita narrazione nella narrazione.
Giove, adirato per gli ultimi fatti, chiama a raccolta gli Dei, i quali, senza indugio, si recano al palazzo celeste, percorrendo la Via Lattea. Giove appare nella sua veste di regnante, seriamente preoccupato che il dilagarsi del male possa nuocere ai Fauni, alle Ninfe, ai Satiri e ai Silvani. Il regnante del cosmo sente la sua responsabilità verso l’ordine universale e deve prendere una decisione rapida per difendere almeno quelle creature che non si sono guastate.
Il prudente accostamento dello sdegno di Giove con quello di Augusto quando assassinarono il Divo Giulio, in tempi storici, ossia fuori della narrazione mitologica, così come il paragone della reggia divina con il Palatino, ci rende partecipi dei grandi eventi divini nella nostra era: Roma e il suo potere politico hanno il compito di difendere il mondo dalle oscure forze caotiche. Noi – Romani – possiamo scegliere da che parte stare, in quanto la colpa descritta non costituisce il nostro “peccato originale” inestirpabile, ma un fatto legato ad un’empietà cosmica che nella nostra generazione può essere combattuta da scelte di campo, appoggiando l’operato di Roma. La visione politica dell’universo, come un regno da gestire, evoca gli equilibri dell’impero romano e probabilmente, la dominante figura di Giove sopra gli altri Dei, non identificati, suggerisce un parallelismo con i rapporti tra Augusto ed il senato. Un senato a cui comunque Augusto riporta le decisioni, cercandone il consenso, esattamente come Giove spiega pazientemente la situazione ai suoi. I quali non reagiscono tutti allo stesso modo: alcuni appoggiano Giove con un trasporto emotivo, amplificandone lo sdegno, altri assentono con tacita e malcelata preoccupazione. Forse nel senato ai tempi di Augusto succedeva lo stesso.
Passiamo al discorso di Giove. Come detto, la catastrofe dell’età del ferro è cosmica: non vige un peccato originale o una causa unica, ma un turbinio verso il sovvertimento dell’ordine divino. La dimensione universale della tragedia è rivelata dall’accostamento narrativo dell’empietà umana alla guerra dei Giganti. I Giganti sono figure mostruose, con serpenti per gambe, e rappresentano le forze oscure, titaniche, caotiche. Essi cercarono di impadronirsi dell’Olimpo stesso, ma il loro sforzo fu reso vano dalla folgore di Giove, il custode del cosmo. Il sangue dei giganti intrise la terra formando un mare da cui si formò l’empia stirpe umana dell’età del ferro. Se nei versetti anteriori si erano enumerate alcune delle nefandezze di quell’età scellerata, adesso Giove racconta la storia di Licaone, alla quale Lui stesso non voleva credere e che alla fine si è rivelata addirittura peggiore di ogni aspettativa. Licaone d’Arcadia, il cui nome è chiaramente riconducibile a “lykos”, lupo in greco, non è un mostro stupido come il Minotauro (testa di toro), ma un regnante freddamente calcolatore, pronto a scavalcare i diritti umani pur di dimostrare le sue tesi. Giove manifesta la sua divinità, ma anche se il popolo comincia a pregare per redimersi, Licaone blocca il processo positivo con il proposito di dimostrare “scientificamente” che colui che si presenta come Giove è in realtà un impostore. Già l’uccisione di un ostaggio è un’aperta violazione al diritto di ospitalità sacro appunto a Giove. Il tentativo di uccisione nel sonno di Giove stesso è la seconda violazione del diritto di ospitalità. Tuttavia, la preparazione delle carni della vittima che vengono fatte bollire e cotte alla griglia induce un naturale orrore e sdegno: questo è un tema ricorrente nella tragedia greca. La punizione di Giove su Licaone è esemplare: i suoi sanguinari propositi, prima orditi con freddezza, lo hanno trasformato in una bestia affamata, condannata a concentrare la sua sete di sangue sul bestiame. L’uomo dunque si è tramutato in bestia, perdendo l’intelletto e la capacità di parola (logos).
Licaone, al momento della narrazione di Giove, è già un problema risolto, ma l’empia follia, personificata dalle Furie, dilaga su tutto il genere umano dell’età del ferro, in maniera tale da far preoccupare Giove più di quanto non si fosse preoccupato durante la guerra dei Giganti. Là la guerra era una, con una causa e una schiera. Gli umani invece sono molti e divisi, ed il male dilaga. Occorre porre un freno, eliminare quella generazione malvagia. Il genere umano sarà distrutto. Eppure con una distruzione totale e irreversibile verrebbe meno una funziona considerata fondamentale dagli Dei, che si chiedono chi porterà l’incenso agli altari (rogant, quis sit latūrus in ārās tūra). L’eterna domanda teologica su che necessità avrebbe un’ipotetica divinità di creare l’uomo trova espressione in queste righe. Anche se il testo non ce lo spiega, possiamo giustificare questa attenzione verso gli umani, secondo le filosofie dell’epoca, con una ricerca di compattezza dell’ordine cosmico. Se nelle zone più basse del cosmo ci fossero forze caotiche ostili all’ordine divino, ci troveremmo in un universo in discordia e continua competizione, in aperto contrasto con l’emanazione ordinata ed armonica descritta all’inizio del primo libro. L’essere umano che applica la pietas e che dal basso del cosmo segue le virtù divine e brucia l’incenso agli Dei, chiude un cerchio perfetto dove l’emanazione divina permette anche un ritorno dal basso verso l’alto per mezzo della provvidenza. Il moto ascendente dell’incenso è spirituale ed armonico, in contrasto con quello discendente del sangue dei giganti, che inzuppa la terra ed il fango. L’uomo quindi sarà salvato proprio per quella ricerca di armonia cosmica che permette una doppia circolazione provvidenziale nella formazione dall’alto al basso e nella celebrazione dal basso all’alto. La Pax Deorum, come armonia cosmica, è la funzione in base alla quale sarà generata la nuova stirpe di esseri umani.
Alla fine del discorso di Giove tutto è pronto per passare ai fatti. Ma questo sarà oggetto del prossimo articolo.
Mario Basile
(Fori Hadriani scripsit, Non Feb. MMDCCLXXII)